Uso del telefono cellulare e malattia professionale: riconosciuta la rendita previdenziale.
La Corte d’Appello di Torino recentemente ha confermato il nesso di causa-effetto tra tumore al cervello, benigno ma invalidante, e l'abuso del cellulare. I dati epidemiologici, i risultati delle sperimentazioni sugli animali
(non contraddetti, allo stato, da altre sperimentazioni), la durata e l’intensità dell’esposizione
che assumono particolare rilievo considerata l’accertata relazione tra esposizione a radiofrequenze da telefono cellulare e rischio di neurinoma del nervo acustico, unitamente alla mancanza di un altro fattore che possa avere cagionato la patologia, complessivamente valutati, consentono di ritenere che sussista una
legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici.
La Corte, con la sentenza del 14 gennaio 2020, ha conformato la precedente decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l'indennità Inail ad un dipendente, tenuto per necessità di lavoro a fare uso del cellulare.
La decisione si pone nel solco di altre, fra cui Cassazione, Sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438.
Il caso, sottoposto all'esame, è stato il seguente:
- il ricorrente, quale referente/coordinatore di altri dipendenti
Telecom, ha utilizzato in maniera abnorme telefoni
cellulari nel periodo 1995-2010, come dimostrato dall’istruttoria
testimoniale (testi M., N., B.);
- in base ad essa si deve infatti ritenere che il ricorrente,
coordinando una quindicina di colleghi, nell’ipotesi più
prudente utilizzasse con loro il telefono per almeno due ore
e mezza al giorno (2 telefonate x 5 minuti x 15 colleghi), e
che, nell’ipotesi maggiore, le ore al telefono diventassero
oltre sette (3 telefonate x 10 minuti x 15 colleghi), a cui si
aggiunge il tempo trascorso al telefono per riferire ai propri
superiori e per coordinarsi con il direttore dei lavori degli
enti e con le imprese esterne che collaboravano nei lavori,
nonché durante il fine settimana, come confermato dal
teste Romeo, figlio del ricorrente;
- inoltre, all’epoca non esistevano strumenti per attenuare
l’esposizione alle radiofrequenze e questa era aggravata dal
tipo di tecnologia utilizzata per i primi telefoni cellulari
(tecnologia ETACS), e dal fatto che spesso l’utilizzo
avveniva all’interno dell’abitacolo di un’autovettura;
- la letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze
nocive dell’uso dei telefoni cellulari: da una parte
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC), facente parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (ente imparziale ed autorevole a livello mondiale)
il 31.5.2011 ha reso nota una valutazione dell’esposizione
a campi elettromagnetici ad alta frequenza,
definendoli come “cancerogeni possibili per l’uomo”
(categoria 2B); dall’altra lo studio Interphone individua
un rischio del 40% superiore per i glioma (famiglia di
tumori cui appartiene anche quello che ha colpito il
ricorrente) negli individui che abbiano usato il cellulare
molto a lungo e per molto tempo; gli unici studiosi che con
fermezza escludono qualsiasi nesso causale tra utilizzo di
cellulari e tumori encefalici sono i proff. Ahlbom e
Repacholi, ma detti autori si trovano in posizione di
conflitto di interessi, essendo il primo consulente di gestori
di telefonia cellulare ed il secondo di industrie elettriche;
- ai risultati a cui sono pervenuti gli studi finanziati dalle
aziende produttrici di telefoni cellulari non può essere
attribuita particolare attendibilità in considerazione
della posizione di conflitto di interessi degli autori, come
ritenuto dalla S.C. nella sentenza n. 17438/2012 in un caso
relativo ad altro tumore encefalico (neurinoma del ganglio
di Gasser);
- la c.t.u. ha accertato la sussistenza del nesso causale;
- pertanto, e considerate le peculiarità del caso concreto
(associazione tra tumore raro ed esposizione rara per durata
ed intensità; periodo di latenza congruo con i valori
relativi ai tumori non epiteliali; il fatto che la patologia
sia insorta nella parte destra del capo del ricorrente,
soggetto destrimane; mancanza di altra plausibile spiegazione
della malattia), deve ritenersi provato un nesso
causale, o quantomeno concausale, tra tecnopatia ed
esposizione, sulla base della regola del “più probabile
che non”;
- i postumi permanenti debbono essere riconosciuti nella
misura del 23%, come da conclusioni del c.t.u., non
contestate da alcuna delle parti.
(omissis)
L’istruttoria testimoniale ha infatti confermato la notevolissima
esposizione del sig. R. alle radiofrequenze per
l’uso del telefono cellulare nel periodo 1995-2010. Infatti,
il teste M., collega dell’appellato dal 1990 al 2010, ha
riferito che l’appellato coordinava la sua attività e quella
degli altri tecnici esterni (di cui l’appellato era superiore
gerarchico), pari complessivamente a 15-20 persone; il
teste ha dichiarato che si sentiva con l’appellato quotidianamente
più volte al giorno, circa 2-3 volte al giorno o
anche di più, con chiamate della durata di 5-10 minuti
ciascuna.
Il teste N., collega dell’appellato dal 2000 al 2011, ha
dichiarato di essersi sentito con lui molto spesso, anche un
paio di volte all’ora, e che le telefonate duravano 5 minuti,
ma anche di meno.
Il teste B., che ha lavorato con l’appellato dai primi anni
‘90 al 1996, ha dichiarato che quest’ultimo coordinava
circa 10-12 colleghi; e di avere contattato l’appellato
almeno 2-3 volte in un giorno, con telefonate di circa 5-
10 minuti ciascuna.
Come rilevato dal Tribunale, le telefonate dell’appellato
intercorrevano anche con il direttore dei lavori, con le
imprese esterne e con i superiori (v. testi M. e B.).
Escludendo quindi i valori massimi (che si ottengono
considerando il numero più elevato di telefonate effettuate
dai tecnici all’appellato e la durata massima di esse,
come indicati dai testi) e prendendo perciò in considerazione
il numero minimo e il numero medio di telefonate di
ciascun tecnico (rispettivamente 2 e 2,5) per il numero di
essi (l5-20 secondo M., 10-12 secondo B.), si ottiene
un’esposizione, secondo le testimonianze di M. e N., da
un minimo di 3,30 ore al giorno (200 minuti) a un medio di
5 ore al giorno (300 minuti), e, secondo la testimonianza di
B., da un minimo di 1 ore e 40 minuti (100 minuti) a un
medio di 3 ore e 50 minuti (230 minuti).
Pertanto, pur con il grado di precisione compatibile con il
fatto di riferirsi a circostanze che, anche a distanza notevole
di tempo, si ripetono durante un periodo lungo, anche
con un inevitabile grado di variabilità, il quadro istruttorio
consente, a parere della Corte, di ritenere provata un’esposizione
a radiofrequenze molto elevata, che, in via del
tutto prudenziale, va quantificata in circa 4 ore al giorno
per tutto il periodo dedotto nel ricorso.
All’epoca non esistevano strumenti che consentissero di
evitare il contatto diretto del telefono cellulare con il viso,
come cuffiette o auricolari (v. teste M., e v. teste N.,
secondo cui le cuffiette, peraltro acquistate personalmente
dai tecnici Telecom, avevano iniziato ad essere utilizzate a
partire dall’inizio del 2000, e, nello stesso senso, v.
teste B.).
È vero, come osservato dall’INAIL, che l’appellato
disponeva di un ufficio dotato di un telefono fisso
(v. teste M.), ma i testi hanno riferito che lo contattavano
sul telefono cellulare in quanto era più facile
reperirlo, considerato che sovente si spostava fuori
dell’ufficio e che era meno agevole rintracciarlo sul
telefono fisso, in quanto in tal caso occorreva passare
per il centralino (v. testi M., N., B.).
È poi emerso che la tecnologia ETACS (che, come si dirà
più oltre con riferimento alla c.t.u. svolta nel presente
grado, emetteva radiofrequenze molto più potenti di
quelle utilizzate attualmente dai telefoni cellulari) è durata
circa 7 anni (teste M., v. anche teste N., che ha dichiarato
che a partire dal 2000 prevaleva la tecnologia GSM; nello
stesso senso, v. teste B.).
Queste circostanze hanno reso l’esposizione, già di per sé
prolungata, particolarmente intensa.
Il figlio dell’appellato, sentito come teste, ha poi confermato
che il padre è destrimane.
Con il terzo motivo di gravame, l’INAIL deduce l’erroneità
della conclusione del Tribunale in ordine all’esistenza
del nesso eziologico tra la patologia e l’esposizione
lavorativa a radiofrequenze.
In particolare:
- osserva in primo luogo che il neurinoma del nervo
acustico non è una malattia tabellata, sicché l’onere di
provare la natura professionale della patologia incombe sul
ricorrente;
- critica la c.t.u. disposta dal Tribunale, evidenziando gli
errori materiali ivi contenuti e sostenendo che essa perviene
a conclusioni errate, poiché non suffragate da una
legge scientifica generale di copertura o quantomeno da
una legge scientifica che abbia un preponderante
consenso;
- deduce che la c.t.u., le cui conclusioni sono state
recepite dal Tribunale, si è basata sulla classificazione
IARC del 2013, senza dare adeguatamente conto di
studi successivi, e non ha correttamente valutato il
significato della classificazione delle radiofrequenze in
relazione all’evidenza cancerogena, ossia come categoria
2B (“possibilmente cancerogeno per l’uomo”), e
quindi la più debole tra quelle utilizzate dall’Agenzia
per classificare agenti che presentino evidenze positive
di cancerogenicità (a fronte della categoria 2A, “probabilmente
cancerogeno per l’uomo” e della categoria
1, “cancerogeno per l’uomo”);
- sostiene che lo studio Interphone deve ritenersi attendibile,
in quanto studio caso-controllo indipendente, pur a
fronte di un solo parziale finanziamento da parte di industrie
di telefoni cellulari e operatori di telefonia mobile,
come pure devono ritenersi attendibili gli studi di Hardell;
detti studi e gli ulteriori, pur con i limiti evidenziati dalla
relazione del dott. Grandi (ricercatore del Dipartimento di
Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale
INAIL), prodotta nel presente grado, non supportano
l’associazione tra utilizzo del telefono cellulare e l’insorgenza
del tumore;
- deduce che, diversamente da quanto sostenuto dal c.t.u.
(e condiviso dal Tribunale), non sono conosciuti i meccanismi
di azione delle radiofrequenze;
- sostiene che non è provato che l’appellato (soggetto
destrimane) usasse il telefono cellulare appoggiandolo
sempre all’orecchio destro;
- deduce inoltre che non è corretto, come ha fatto il
Tribunale, inferire dalla coesistenza di due fenomeni rari
(nel caso di specie, tumore raro ed esposizione rara a
radiofrequenze) un nesso di causa-effetto tra di essi;
- sostiene infine che erroneamente è stato ritenuto un
periodo di latenza del tumore (secondo la dottrina scientifica,
almeno 10 anni) compatibile con l’esposizione a
radiofrequenze sin dal 1995, considerato che il tumore (a
lentissima crescita), si è manifestato già nel dicembre
2009, e, pertanto, non risulta applicabile il rischio individuale
pari a 1,44, riportato invece dal c.t.u.
Alla luce della c.t.u. disposta nel presente grado anche
questo motivo di gravame è infondato.
I Consulenti d’Ufficio si sono correttamente attenuti al
quesito formulato dalla Corte con ordinanza del
16.1.2019, in cui era richiesto di svolgere gli accertamenti
peritali basandosi su un’esposizione pari a 4 ore al giorno
(come dimostrata dall’istruttoria testimoniale di cui si è già
detto), seppure per mero errore, nel verbale di conferimento
incarico del 19 marzo 2019, si sia fatto riferimento
al quesito formulato nel primo grado, che non precisava la
durata dell’esposizione. Pertanto, in conformità ai tempi di
esposizione indicati nel quesito conferito, è stato stimato
un tempo di utilizzo lavorativo del telefono cellulare pari a
840 ore/anno (4 ore x 210 giorni lavorativi), con un tempo
stimato complessivo di utilizzo nell’intervallo di 15 anni
intercorso tra il 1995 ed il 2010 pari a 12.600 ore (840 ore/
anno x 15 anni) (v. pag. 51 c.t.u.). I periti hanno inoltre
considerato che, come emerso dall’istruttoria, i telefoni
cellulari utilizzati dall’appellato sino alla fine del 1999
erano analogici (utilizzavano la tecnologia ETACS) e
quindi, dal 2000, erano digitali (utilizzavano la tecnologia
GSM), evidenziando che “I telefoni analogici e quelli
digitali basati su tecnologia GSM 2G erano caratterizzati
da emissioni di radiofrequenze (RF) molto superiori
rispetto a quelli digitali attuali 3G e 4G, con livelli di
intensità di emissioni diRFdi quasi due ordini di grandezza
superiori (IARC, 2013), ovvero quasi 100 volte superiori”
(v. pagg. 51-52 c.t.u., affermazione tratta dalla Monografia
IARC (2013) sulle radiofrequenze, come precisato dai
Consulenti d’Ufficio a pag. 121 della relazione).
Premesso che il neurinoma acustico (o schwannoma vestibolare,
indicato per brevità nella c.t.u. come “NA”),
tumore cerebrale benigno, raro e a crescita lenta, è caratterizzato
da un periodo di latenza dall’inizio dell’esposizione
ad un fattore di rischio fino al momento della
diagnosi di malattia pari a non meno di 10-15 anni (v.
pag. 54 e segg.), i Consulenti d’Ufficio hanno citato i
numerosi studi sulla materia, dando atto che la maggior
parte di essi sono studi caso-controllo che sono stati
condotti dal gruppo di lavoro Interphone e dal gruppo di
ricerca dell’Università di Orebro, Svezia, guidato dal prof.
Hardell, evidenziandone le caratteristiche e le
metodologie, nonché i limiti e le critiche svolte su di
essi dalla letteratura scientifica (v. pag. 58 e segg.).
Dopo lo studio Interphone pubblicato nel 2010 sulla
relazione tra esposizione aTC(telefono cellulare) e gliomi
e meningiomi (tra cui non era quindi incluso il NA), “Nel
2011 il gruppo di studioINTERPHONE pubblicava, in un
altro articolo, i risultati dello studio internazionale casocontrollo
su uso di telefoni cellulari e rischio di sviluppare
neurinomi dell’acustico, che comprendeva più di 1.000
casi e oltre 2.000 controlli arruolati tra il 2000 e il 2004
(INTERPHONE, 2011).
Questo studio non ha riscontrato differenze nell’esposizione
pregressa a TC in casi e controlli per ‘utilizzo regolare’
definito sulla base di almeno una chiamata alla
settimana.
Al contrario, ha osservato un eccesso di rischio statisticamente
significativo di sviluppare NA (di quasi 3 volte nei
soggetti esposti, rispetto ai non esposti), nei soggetti classificati
nella classe più alta di esposizione, corrispondente
ad un utilizzo complessivo di TC superiore a 1.640 ore
(traducibili in durate medie di esposizione di 1 ora al
giorno per 4 anni, o di 2 ore al giorno per 2 anni, o di
mezz’ora al giorno per 8 anni)”, evidenziando inoltre che i
risultati dello studio mostravano nella classe con più alta
esposizione cumulativa (utilizzo complessivo di telefono
cellulare maggiore o uguale a 1640 ore) un’associazione
statisticamente significativa del NA solo con l’uso ipsilaterale
di telefono cellulare (OR, o Odds Ratio = 3.74),
sicché “Dal momento che, come anche osservato da Cardis
(Cardis, 2008), le radiofrequenze (RF)/emissioni elettromagnetiche
emesse dai telefoni portatili vengono
assorbite soprattutto dal lato del capo al quale viene
accostato l’apparecchio telefonico durante l’utilizzo (c.d.
utilizzo ipsilaterale) e che con l’aumentare della distanza
del telefono dal capo la dose di radiazioni elettromagnetiche
assorbita dai tessuti diminuisce bruscamente, il riscontro
di un’associazione statisticamente significativa delNA
solo con l’uso ipsilaterale diTCsupporta l’ipotesi che leRF
emesse dai TC svolgano un ruolo causale nell’induzione/
sviluppo di NA”.
Con riferimento ad una delle osservazioni dell’appellante
sopra riportate, rileva la Corte che, non contestato e
confermato dalla testimonianza del figlio dell’appellato
che quest’ultimo è destrimane, il fatto che si tenda ad usare
il telefono, esclusivamente o quasi, appoggiandolo all’orecchio
del lato del corpo “dominante”, rientra nel fatto
notorio essendo usualmente riscontrabile nell’esperienza
comune.
I Consulenti d’Ufficio hanno poi citato la classificazione
dello IARC (Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro) del 2011, secondo cui le radiofrequenze
sono “possibilmente cancerogene per
l’uomo”, valutazione confermata nella monografia del
2013 sulle radiazioni non ionizzanti, evidenziando che
nell’aprile 2019 un Advisory Group della IARC, composto
da 29 ricercatori provenienti da 19 paesi, ha
inserito le radiofrequenze tra gli agenti per cui è
ritenuta prioritaria una rivalutazione di cancerogenicità
da parte della IARC nel periodo 2020-2024
(IARC Monographs Priorities Group, 2019). Hanno
quindi menzionato gli studi successivi (v. pagg. 68-69).
Nella tabella redatta dai Consulenti d’Ufficio alle pagg. 70
e 71 della perizia sono riportate le caratteristiche e i
risultati degli studi epidemiologici pubblicati sull’associazione
tra utilizzo di TC e NA, relativi al rischio di NA
stimato per i soggetti con la più alta esposizione cumulativa
in ciascuno studio, in termini di durata dell’esposizione,
di durata cumulativa del tempo di esposizione o
della durata dell’abbonamento telefonico, divisi anche per
utilizzo ipsilaterale e controlaterale rispetto all’insorgenza
del tumore.
Come rilevato dai Consulenti d’Ufficio, dall’esame della
tabella emerge che la maggioranza degli studi mostra
eccessi di rischio associati ad elevata durata di utilizzo o
esposizione cumulativa a TC, che in vari studi sono statisticamente
significativi, con più alti rischi associati all’utilizzo
ipsilaterale di TC.
Nella perizia è evidenziato “il fatto che negli studi in cui il
rischio di NA è stimato sulla base del numero di ore
cumulative di utilizzo, la categoria con la più alta esposizione
cumulativa stimata (che trova il monte ore più alto
di 1640 ore nello studio INTERPHONE 2011) ha un
limite che è almeno circa 8 volte più basso del numero
di ore (12.600 ore circa) di utilizzo di TC stimato nel caso
del Sig. Romeo” (v. pag. 69 c.t.u.).
I Consulenti d’Ufficio hanno poi esaminato le evidenze da
studi sperimentali su animali, pubblicati successivamente
alla monografia IARC del 2013, di cui uno condotto
dall’Istituto Ramazzini e l’altro dal National Toxicology
Program (NTP) statunitense: il primo ha osservato un
incremento statisticamente significativo di Schwannoma
delle cellule cardiache di Schwann a carico dei ratti
maschi, anche se stimato su un numero limitato di casi
(3 casi nel gruppo a più alta esposizione vs. 0 casi nel
gruppo non esposto), ed un incremento non statisticamente
significativo di iperplasia delle cellule cardiache di
Schwann, che costituisce una lesione pre-tumorale, in
entrambi i sessi (Falcioni et al., 2018); e anche il secondo
ha mostrato, per i ratti maschi, un incrementato numero di
casi di Schwannoma cardiaco, rispetto ai ratti maschi non
esposti, che era statisticamente significativo sia per esposizione
a radiofrequenze CDMA (3 casi nel gruppo con
esposizione intermedia, 6 casi nel gruppo con la più alta
esposizione e 0 casi tra i non esposti) che per esposizione a
quelle da GSM (5 casi nel gruppo più esposto e 0 casi tra i
non esposti) (NTP, 2018).
I Consulenti d’Ufficio hanno precisato che “gli Schwannomi
cardiaci sono dello stesso tipo istologico dei neurinomi
del nervo acustico (che, infatti, sono denominati
anche Schwannomi vestibolari), cosa che supporta una
relazione causale tra esposizione a radiofrequenze e incidenza
di NA” (v. c.t.u. pag. 76).
In base a tutti questi elementi, i Consulenti d’Ufficio
hanno concluso che “Nel caso concreto specifico in
esame, il rischio derivante dall’utilizzo professionale di
telefono cellulare risulta decisamente aggravato in relazione
principalmente al lungo periodo di esposizione (15
anni) ed all’elevata intensità dell’esposizione stessa,
quest’ultima dovuta sia alla tipologia di apparecchi telefonici
cellulari utilizzati (ETACS e quindi GSM 2G, con
livelli di emissione quasi 100 volte superiori rispetto ai più
moderni telefoni cellulari), che all’elevato numero di ore
di utilizzo dell’apparecchio telefonico stesso (con un’esposizione
media di 840 ore/anno, con conseguente esposizione
complessiva in 15 anni stimata nell’ordine di
12.600 ore).
Pertanto, anche alla luce delle risultanze dei più recenti
studi sugli animali condotti da NTP e dall’Istituto Ramazzini
(che mostrano eccessi di tumori dello stesso tipo
istologico del NA, anche se in altra sede) e dalle recenti
indicazioni dell’Advisory Group dellaIARCsulla necessità
di una prioritaria rivalutazione da parte della IARC della
cancerogenicità delle radiofrequenze, considerando le
risultanze degli studi epidemiologici disponibili che, per
quanto non del tutto concordanti, mostrano comunque
frequentemente un eccesso di casi di NA in presenza di
prolungata esposizione o di esposizioni intense, è dato
ritenere che, nello specifico caso in esame, con criterio
di elevata probabilità logica, si possa ammettere un nesso
eziologico tra la prolungata e cospicua esposizione lavorativa
a radiofrequenze emesse da telefono cellulare e la
malattia denunciata dal periziato all’INAIL (neurinoma
dell’ottavo nervo cranico destro)” (v. conclusioni preliminari
a pagg. 77-78, ribadite a pagg. 123-124 nelle conclusioni
e risposte ai quesiti). Le conclusioni sono fondate
su un accurato ed aggiornatissimo esame delle fonti della
letteratura scientifica, applicata alle peculiarità del caso
concreto (per quantità e durata dell’esposizione), in
assenza di fattori alternativi di rischio, secondo standard
di certezza probabilistica (“più probabile che non”).
Rispetto alle conclusioni del Consulenti d’Ufficio, i Consulenti
INAIL hanno svolto articolate osservazioni (riportate
a pagg. 79-84 della relazione), mentre i difensori
dell’appellato hanno sottolineato la posizione di conflitto
di interesse di alcuni autori di studi che hanno negato la
cancerogenicità delle radiofrequenze (v. pagg. 84-97 c.t.
u.), in particolare nell’ambito della letteratura citata dall’INAIL
(v. pagg. 94-95).
Ritiene la Corte che i Consulenti d’Ufficio abbiano fornito
esaustive risposte in merito alle osservazioni dei
Consulenti di parte appellante.
In particolare:
1) i dati relativi all’esposizione su cui si sono basati i
Consulenti d’Ufficio non sono, come sostenuto dai Consulenti
INAIL, tratti “sostanzialmente dalle informazioni
anamnestiche riferite dall’assicurato”, bensì, come già
osservato, oggetto del quesito formulato dal Collegio
avuto riguardo alle circostanze comprovate all’istruttoria
testimoniale già sopra descritta;
2) con riferimento alle critiche sull’attendibilità degli
studi secondo cui sussiste un nesso eziologico tra esposizione
a radiofrequenze e il neurinoma dell’acustico, i
Consulenti d’Ufficio hanno svolto le seguenti articolate
repliche:
a) quanto alle possibili distorsioni (“bias”), i Consulenti
d’Ufficio hanno illustrato le differenze tra gli studi casocontrollo
e gli studi di coorte, precisando che nella materia
in esame la letteratura è quasi interamente costituita da
studi caso-controllo. In questo tipo di studio (a differenza
degli studi di coorte, da cui si ricava il rapporto tra l’incidenza
della malattia nella popolazione esposta al fattore di
rischio e l’incidenza della stessa malattia nella popolazione
non esposta), il rischio relativo (RR) è approssimato da un
altro indicatore di rischio, ovvero l’Odds Ratio (OR), che
viene calcolato sulla base del rapporto tra la frequenza di
esposizione al fattore di rischio tra i casi (malati) rispetto
alla frequenza di esposizione al fattore di rischio tra i
controlli (non malati).
Ciò rende possibili misclassificazioni non differenziali
(che interessano sia i casi che i controlli nella stessa
misura), le quali, come evidenziato dai Consulenti d’Ufficio,
determinano sempre una sottostima del rischio
rispetto al rischio reale, e misclassificazioni differenziali
dell’esposizione (errori di classificazione che interessano
in diversa entità i casi rispetto ai controlli), le quali
possono condurre sia ad una sovrastima che ad una sottostima
del reale rischio di malattia dovuto all’esposizione, e
la più seria minaccia alla validità dei risultati è costituita da
una forma di misclassificazione differenziale dell’esposizione
denominata “recall bias”, dovuta alla possibilità che i
soggetti che risultano affetti da malattia tumorale ricerchino
nella propria memoria dei dati relativi alla propria
pregressa esposizione a possibili fattori di rischio per la
salute che possano avere determinato tale malattia.
Tuttavia i risultati degli studi disponibili (lo studio di
Vrijheid et al., 2009, lo studio di Aydin et al., 2011, e lo
studio di Petterson et al., 2015) indicano che è improbabile
che gli studi su esposizione aTCe rischio diNAsiano
stati affetti da una misclassificazione differenziale dell’esposizione
a RF da TC, tale da determinare una sovrastima
dell’esposizione tra i casi rispetto ai controlli e,
pertanto, una conseguente sovrastima del rischio di NA
associato all’esposizione a RF da TC; al contrario, sia i
risultati di detti studi, che quelli di altri studi che hanno
valutato, in soggetti sani, la validità dell’esposizione aTC
“autoriferita” (ovvero riferita dagli stessi soggetti inclusi
nello studio e rilevata per mezzo di questionario o intervista
ad essi somministrati), indicano la presenza di una
fortemisclassificazione non differenziale dell’esposizione
(Samkange-Zeeb et al., 2004; Toledano et al., 2014;
Vanden Abeele et al., 2013), con conseguente sottostima
della forza dell’associazione tra esposizione aTCe rischio
di NA, rispetto al rischio reale, sicché le stime di rischio
(O.R.) ottenute nei diversi studi sarebbero fortemente
sottostimate e il rischio reale di sviluppare NA sarebbe
molto più alto di quello osservato negli studi stessi
(v. pagg. 99-103 c.t.u.); b) anche quanto alla ipsilateralità
dell’utilizzo del telefono cellulare rispetto al lato di
comparsa del tumore gli studi disponibili (Shimizu e
Yamaguchi, 2012) evidenziano la possibilità di una
forte misclassificazione non differenziale, con conseguente
sottostima (v. pag. 103 c.t.u.);
c) a differenza di quanto sostenuto dai Consulenti di parte
INAIL, un effetto dose-risposta, cioè un significativo
aumento del rischio di sviluppare la malattia tumorale
(NA) all’aumentare della dose cumulativa di esposizione a
RF da TC, è presente nei risultati della pooled analysis di
Hardell et al. (2013), come da tabella riportata a pag. 104
della relazione, che mostra un rischio di NA associato
all’uso di telefoni wireless progressivamente crescente
all’aumentare della dose cumulativa di esposizione a TC
(calcolata in base alle ore di utilizzo di TC): v. pagg. 103-
105 c.t.u.;
d) un possibile motivo della mancanza di un effetto doserisposta
nello studio Interphone (2011) e in altri studi è che
le categorie di esposizione cumulativa utilizzate fossero
troppo basse: per esempio, nello studio Interphone il limite
inferiore per la categoria di esposizione cumulativa più alta
era posto a sole 1.640 ore di utilizzo di TC, corrispondenti a
meno di mezz’ora al giorno per 10 anni. Come osservato
nella relazione peritale, una dose di esposizione al di sotto di
questo limite potrebbe essere non sufficiente a determinare
lo sviluppo di NA (v. pag. 105 c.t.u.). Si tratta peraltro di
una dose di esposizione, come emerge dalla perizia, assolutamente
non confrontabile con la massiccia e prolungata
esposizione a radiofrequenze subita dall’appellato per ben
15 anni;
e) l’affermazione dei Consulenti INAIL secondo cui soggetti
audiolesi protesizzati, che possiedono sussidi uditivi
che utilizzano quotidianamente per l’intera giornata con
annessa funzione bluetooth, non hanno mai fatto riscontrare
casi di neurinomi dell’acustico, non è supportata da
alcun riferimento bibliografico (v. pag. 107 c.t.u.);
f) diversamente da quanto sostenuto dai Consulenti
INAIL, il trend della patologia per cui è causa (schwannoma
dell’VIII nervo cranico) mostra un aumento, in
coincidenza con la diffusione della telefonia cellulare, di
detta malattia nel corso degli ultimi decenni. I Consulenti
d’Ufficio hanno indicato, nelle pagg. 55-57 della relazione,
i diversi studi sulla questione, rilevando che,
secondo alcuni di essi, l’aumento di incidenza della malattia
sarebbe attribuibile al miglioramento delle tecniche
strumentali - basata sulla diffusione di nuove tecnologie,
ad esempio TAC e RMN - utilizzate per pervenire alla
diagnosi di tale tumore; ma osservando tuttavia che studi
basati sui dati più recenti mostrano un ulteriore incremento
di incidenza di NA, anche riferito a periodi in cui la
diffusione dei migliori strumenti di diagnostica di questi
tumori era già avvenuto (Kleijwegt et al., 2016: aumento
nella regione di Leyden dell’incidenza di NA di oltre 3
volte in un arco temporale di 11 anni intercorrente tra il
2001 al 2012; Marinelli et al., 2018: aumento dell’incidenza
diNAin Minnesota,USA,di oltre 2 volte in unarco
temporale di 11 anni intercorrente tra il 1995 al 2016;
sempre negli USA, il Central Brain Tumor Registry,
CBTRUS, ha pubblicato report annuali dal 2007 al 2016
con dati registrati dal 2004 al 2013 che evidenziano un
raddoppio dell’incidenza annuale di NA: da 0,88 a 1,73 x
100.000); a pag. 108 della relazione hanno richiamato i
dati del registro tumori danese che evidenziano un incremento
nell’incidenza di tumori cerebrali, con un aumento
del40%tra gli uomini e del29%tra le donne tra il 2001 e il
2010 (Sundhedsstyrelsen, 2010).
È quindi condivisibile la conclusione dei Consulenti
d’Ufficio secondo cui è improbabile che l’incremento
di incidenza di NA sia attribuibile unicamente alla possibilità,
derivante dell’affinamento delle metodiche diagnostiche
di tale tumore o anche da una maggiore
accessibilità della popolazione alle strutture sanitarie,
di ottenere più diagnosi di NA.
3)Conriferimento agli studi diNTPe dell’Istituto Ramazzini,
alle osservazioni critiche dei Consulenti INAIL sulla
loro validità scientifica, anche mediante richiamo al
recentissimo articolo pubblicato dall’International Commission
on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) su
Health Physics, i Consulenti d’Ufficio (v. pagg. 108-113
della relazione) hanno esaustivamente replicato che: - si
tratta dei più grandi studi sperimentali su animali condotti
finora e sono caratterizzati da elevata standardizzazione dei
protocolli di ricerca e da alta qualità dei metodi utilizzati;
- lo scopo principale degli studi sperimentali sui tumori
condotti sugli animali è quello di valutare se l’esposizione
ad un sospetto agente cancerogeno provochi o meno
eccessi di tumori nei gruppi di animali esposti. Pertanto
il fatto che, per gli animali oggetto di studio, possano essere
previsti tempi e modalità di esposizione differenti rispetto
a quelli degli esseri umani (per i roditori, a differenza che
per l’uomo, “total body” e per l’intera vita), non rende i
risultati degli studi meno validi.
Inoltre, con riferimento all’osservazione della difesa dell’INAIL,
nel corso della discussione orale, circa l’inattendibilità
di questi studi in quanto non effettuati sull’uomo,
la Corte ritiene esaustiva e condivisibile la replica dei
Consulenti d’Ufficio (anche mediante richiamo a fonti
di letteratura scientifica sullo studio del NTP) secondo cui
il criterio razionale per condurre studi di cancerogenicità
in modelli animali “si basa su dati sperimentali che
mostrano che ogni agente noto come cancerogeno nell’uomo,
quando adeguatamente testato, ha mostrato di
essere cancerogeno negli animali (IARC, 2006) e che
quasi un terzo dei cancerogeni umani sono stati identificati
dopo che effetti cancerogeni sono stati trovati in studi
ben condotti sugli animali (Huff, 1993). Non c’è ragione
di credere che un agente fisico come le radiofrequenze
possa danneggiare i tessuti animali, ma non i tessuti
umani” (Melnick, 2019, citato alle pagg. 76-77 e 109
della relazione). Le sperimentazioni sulla cancerogenicità
di agenti o sostanze vengono usualmente eseguite su animali,
quali i roditori, che presentano elementi di similitudine
con gli uomini, sicché non si può negare
pregiudizialmente valore scientifico ai risultati di detti
studi;
- il fatto che l’eccesso di tumore sia stato riscontrato
soltanto nei ratti (e quasi esclusivamente di sesso
maschile) non inficia la validità dello studio, considerato
che lo schwannoma cardiaco insorge in diverse varietà di
ceppi di ratti (e con maggior frequenza nei maschi), ma
non è mai stato osservato nei topi;
- nonostante, nello studio dell’Istituto Ramazzini, l’esposizione
dei ratti sia avvenuta alla dose massima testata, il
tasso di assorbimento specifico conseguente all’esposizione
era di poco superiore al limite massimo per irradiazione
al corpo intero per l’uomo; mentre, quanto allo
studio del NTP, pur essendo la dose di esposizione molto
superiore al limite massimo di esposizione ammissibile per
irradiazione al corpo intero per l’uomo, la dose assorbita a
livello locale è solo una piccola parte della dose somministrata
a tutto il corpo, e, in particolare, per il cervello, la
dose assorbita è stata stimata in circa il 10% della dose
totale somministrata a tutto il corpo;
- il numero di casi di tumore riscontrato negli animali è
statisticamente significativo: nello studio di NTP, 6 casi
nel gruppo a più alta esposizione a RF daCDMAe 5 casi in
quello con più alta esposizione a RF da GSM, mentre
nessun caso si è verificato nel gruppo non esposto; nello
studio dell’Istituto Ramazzini, 3 casi osservati nel gruppo a
più alta esposizione e nessuno nel gruppo non esposto;
- in merito alla diversa localizzazione degli schwannomi
riscontrati nei ratti esposti negli studi dell’NTP e dell’Istituto
Ramazzini (localizzazione a livello cardiaco invece
che a livello cerebrale), appare probabile che la modalità
di irradiazione degli animali abbia influito nel determinare
questo risultato, in quanto la somministrazione di RF è
stata indirizzata a tutto il corpo e non concentrata solo
sulla testa degli animali da esperimento, come invece
avviene per l’esposizione a RF negli utilizzatori di TC;
- gli schwannomi cardiaci sono dello stesso tipo istologico
dei neurinomi del nervo acustico (che, infatti, sono denominati
anche schwannomi vestibolari), cosa che supporta
una relazione causale tra esposizione a radiofrequenze e
incidenza di NA. Pertanto, il fatto che i NA siano tumori
benigni, al contrario degli schwannomi cardiaci maligni
osservati nei ratti negli studi del NTP e dell’Istituto
Ramazzini, appare irrilevante, considerato che questi
studi dimostrano che l’esposizione a RF può determinare
una trasformazione neoplastica delle cellule di Schwann,
processo che sia i tumori benigni che i tumori maligni
hanno in comune;
- lo studio del NTP ha concluso affermando che i risultati
dimostrano una chiara evidenza di attività cancerogena
delle RF (NTP, 2018); - l’effettuazione di confronti multipli
nelle analisi condotte nei due studi del NTP e dell’Istituto
Ramazzini ha sicuramente aumentato il rischio che
si verificassero associazioni spurie in questi due studi,mala
probabilità che tre analisi indipendenti abbiano trovato
solo per caso un incremento significativo di sviluppare
tumori dello stesso tipo istologico e nella stessa sede
anatomica è bassissima, anche considerando i molti confronti
effettuati in analisi, ciò che supporta in maniera
inequivocabile l’effetto cancerogeno delle RF;
- la presenza di un effetto cancerogeno è supportata anche
dall’osservazione di un significativo aumento del danno al
DNA, valutato per mezzo della presenza di rotture del
DNA con la metodica Comet assay, in vari organi, tra cui
soprattutto il cervello, sia in ratti che in topi (Wyde,
2016);
- diversamente da quanto sostenuto dai Consulenti
INAIL, le analisi sono state condotte “in cieco” (v. articolo
di Melnick del 2019, in risposta alle critiche dell’INCIRP
riguardo allo studio del NTP);
4) In merito alla motivazione per la quale l’Advisory Group
della IARC ha inserito le radiofrequenze tra gli agenti per
cui è ritenuta prioritaria una rivalutazione di
cancerogenicità da parte della IARC nel periodo 2020-
2024 (secondo i Consulenti INAIL non per motivi di
particolare allarme, ma in quanto rivalutazione rientrante
nelle normali procedure di aggiornamento periodico delle
valutazioni di evidenza cancerogena promosse dall’Agenzia),
nella relazione peritale è trascritta la tabella riportata
nell’articolo, dalla quale si ricava che le radiazioni non
ionizzanti (radiofrequenze) sono tra gli agenti per i quali è
raccomandata una rivalutazione urgente (“high priority”)
della cancerogenicità per l’uomo, indicazione, specificata
nella tabella stessa, motivata dal fatto che le nuove evidenze
derivanti da test biologici e meccanicistici “richiedono
una rivalutazione della classificazione”. Nell’articolo
dell’Advisory Group è inoltre specificato che la priorità per
la rivalutazione è stata assegnata sulla base di evidenze
sull’esposizione umana e in base al grado di evidenza
disponibile per valutare la cancerogenicità (v. pagg.
113-115 c.t.u.);
5) Quanto alle osservazioni dei Consulenti INAIL circa
l’incompatibilità dell’evoluzione della patologia dell’appellato
(essendo il tumore, già nel 2010, di dimensioni pari
a 2,6 cm, a fronte di un ritmo di crescita di circa 1,5 mm
all’anno) e i periodi di latenza della stessa (oltre 15-20
anni, non meno di 10-15 anni), i Consulenti d’Ufficio
hanno osservato che, secondo l’autore citato dai Consulenti
INAIL (Dott. P. F., Istituto Besta di Milano), il ritmo
di crescita del tumore, di circa 1,5mmall’anno, si riferisce
a circa il 75% dei neurinomi dell’acustico, mentre un
quarto di essi ha tendenza a crescere più rapidamente e
in maniera più aggressiva (v. pag. 116 c.t.u.). Inoltre, i
Consulenti d’Ufficio, alle pagg. 116-117 della relazione,
hanno citato ampia letteratura scientifica da cui risultano
tassi di crescita del neurinoma dell’acustico piuttosto
variabili. In particolare, in caso di NA caratterizzati da
fenomeni cistici ed emorragici (come quello dell’appellato),
sono stati osservati tassi di crescita di oltre 4 mm/
anno (Paldor et al., 2016), e nella revisione di Paldor
vengono citati anche alcuni case reports nei quali sono
stati descritti casi diNAcon tassi di crescita fino a 25 mm/
anno (Fayad et al., 2014).
Appare dunque condivisibile la conclusione sul punto dei
Consulenti d’Ufficio secondo cui “I tassi di crescita delNA
osservati nella letteratura scientifica, la presenza nel caso
in esame di fenomeni cistico-necrotici (anche citati dai
CTP INAIL) e il lungo periodo intercorso tra la prima
esposizione e la diagnosi di NA (15 anni), rappresentano
elementi certamente non idonei a giustificare una esclusione
del nesso causale tra esposizione a RF da TC e
insorgenza di NA, così come sostenuto dai CTP INAIL.
Al contrario, tali dati rappresentano elementi assolutamente
compatibili con la sussistenza, nel caso in esame, del
riscontro di unNAdelle dimensioni di 2.6 cm al anni a RF
da TC” (v. pag. 117).
6) Pertanto, considerato il periodo di esposizione dell’appellato
alle radiofrequenze (dal 1995 al 2010, anno in cui
gli è stato diagnosticato il NA), il tempo intercorso tra
l’inizio dell’esposizione e la comparsa del tumore (pari a15
anni, e non a 4 anni come sostenuto dai Consulenti
INAIL) è assolutamente compatibile con l’induzione e
lo sviluppo delNAsulla base dei dati di letteratura, anche
considerando 5 anni per l’iniziazione del tumore e 10 anni
per il suo sviluppo. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto
dalla difesa dell’appellante nel corso della discussione
orale, non vi è contraddizione tra quanto argomentato dai
Consulenti d’Ufficio alle pagg. 115-118 in merito alla
latenza della malattia, al suo sviluppo e alle dimensioni
del tumore al momento della diagnosi nel 2010 (2,6 cm), e
quanto scritto alle pagg. 57-58 della relazione sul periodo
di latenza riconosciuto nella letteratura scientifica
(almeno 10-15 anni), avendo i Consulenti d’Ufficio motivato
sulla compatibilità tra il periodo di latenza della
malattia e le dimensioni del tumore, menzionando (a
differenza dei Consulenti INAIL) copiosa letteratura
scientifica sull’estrema variabilità della crescita media
del tumore, che ha registrato anche casi di valori massimi
pari a 17 mm/anno e addirittura fino a 25 mm/anno (v.
pagg. 116-117 c.t.u.).
7) Non vi è contraddizione tra l’affermazione dei Consulenti
d’Ufficio (v. nota 25 a pag. 70 della relazione)
secondo cui “Appare quindi improbabile che si possano
vedere gli eventuali effetti dell’uso diTCsull’incidenza dei
NA, almeno sui dati fino al 2010, data la diffusione
relativamente recente dei TC e il lungo periodo di induzione
di questi tumori” e l’affermazione dell’esistenza del
nesso eziologico nel caso di specie, poiché la frase di cui
sopra è evidentemente riferita al fatto che appare improbabile
che negli studi epidemiologici si potessero vedere
eventuali effetti dell’uso di telefono cellulare, in quanto
nelle popolazioni esaminate da tali studi l’inizio dell’esposizione,
per la gran parte dei soggetti, era troppo recente,
mentre, nel caso concreto in esame, l’esposizione dell’appellato
ha avuto inizio nel 1995, ovvero 15 anni prima
della diagnosi del tumore (NA) ed in un periodo storico in
cui i TC erano ancora poco diffusi nella maggior parte dei
paesi europei (v. pagg. 118-119 c.t.u.).
I Consulenti d’Ufficio hanno pertanto ravvisato il nesso
causale tenendo correttamente in considerazione la concreta
esposizione dell’appellato alle radiofrequenze, che,
per le sue peculiarità (durata ed intensità conseguente
all’uso abnorme del telefono cellulare), presenta caratteristiche
del tutto diverse da quelle medie riscontrate in
generale dalla popolazione nel periodo per cui è causa;
8) con riferimento alle conclusioni dei Consulenti INAIL,
che, al fine di escludere il nesso causale, richiamano il
documento dell’ISS, rapporto ISTISAN 19/11, i Consulenti
d’Ufficio hanno esaustivamente replicato che: “il
rapporto ISTISAN su RF e tumori è stato criticato dall’associazione
Medici per l’Ambiente (ISDE, acronimo di
International Society of Doctors for Environment) per varie
ragioni (Di Ciaula, 2019), tra cui: la selezione degli studi
inclusi nelle meta-analisi presentate; l’interpretazione
delle associazioni osservate tra RF e tumori intracranici;
l’uso inappropriato dei dati sull’andamento dell’incidenza
dei tumori cerebrali per confutare l’associazione tra RF e
tumori cerebrali; il non aver tenuto conto nella loro
valutazione dei risultati di recenti studi sperimentali su
animali, ..., che hanno mostrato effetti cancerogeni su ratti
(NTP, 2018; Falcioni et al., 2018) e, soprattutto, per non
avere fatto conseguire alla dichiarata incertezza sugli
effetti associati ad un uso intenso e prolungato di TC
raccomandazioni più stringenti sui limiti di esposizione a
RF, in particolare per i bambini e gli adolescenti, che
potrebbero essere maggiormente suscettibili a tali effetti
(Di Ciaula, 2019)” (v. pag. 119 c.t.u.).
I Consulenti d’Ufficio hanno poi menzionato il rapporto
della ANSES (Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza
Sanitaria per Alimentazione Ambiente e Lavoro)
sugli effetti delle onde emesse dai telefoni mobili sulla
salute, che conclude segnalando che gli studi scientifici
pubblicati sino ad oggi non permettono di escludere la
comparsa di effetti biologici per l’uomo oltre certe soglie di
esposizione a RF da TC, evidenziando inoltre che il 76%
dei telefoni cellulari esaminati emette radiofrequenze
superiori al limite massimo raccomandato dall’ICNIRP
per esposizione di testa e tronco (v. pagg. 119-121 c.t.u.).
I Consulenti d’Ufficio, a parere della Corte, hanno replicato
punto per punto alle osservazioni dei Consulenti
INAIL, menzionando copiosa letteratura scientifica a
supporto delle proprie argomentazioni, e fornendo, in
conclusione, solidi elementi per affermare un ruolo causale
tra l’esposizione dell’appellato alle radiofrequenze da
telefono cellulare e la patologia per cui è causa.
I dati epidemiologici, i risultati delle sperimentazioni sugli
animali (non contraddetti, allo stato, da altre sperimentazioni
dello stesso tipo), la durata e l’intensità dell’esposizione
(assolutamente peculiari per la loro abnormità)
che assumono particolare rilievo considerata l’accertata - a
livello scientifico - relazione dose-risposta tra esposizione a
radiofrequenze da telefono cellulare e rischio di neurinoma
dell’acustico, unitamente alla mancanza di un
altro fattore che possa avere cagionato la patologia, complessivamente
valutati, consentono di ritenere che, caso
specifico, sussista una legge scientifica di copertura che
supporta l’affermazione del nesso causale secondo criteri
probabilistici (“più probabile che non”).
In effetti, buona parte della letteratura scientifica che
esclude la cancerogenicità dell’esposizione a radiofrequenze,
o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte
ad opposte conclusioni non possano essere considerate
conclusive, come evidenziato anche dai Consulenti d’Ufficio
a commento delle osservazioni della difesa dell’appellato
(riportate alle pagg. 84-97 della relazione), versa in
posizione di conflitto di interessi, peraltro non sempre
dichiarato: si veda in particolare, a pag. 94 della relazione,
l’osservazione della difesa dell’appellato (in alcun modo
contestata dalla controparte) secondo cui gli autori degli
studi indicati dall’INAIL, nominativamente elencati,
sono membri di ICNIRP e/o di SCENIHR, che hanno
ricevuto, direttamente o indirettamente, finanziamenti
dall’industria.
I Consulenti d’Ufficio hanno al riguardo osservato: “Inoltre,
anche alla luce dell’ampia documentazione sui conflitti
di interesse di diversi ricercatori coinvolti nello
studio INTERPHONE, pure prodotta dai consulenti dell’appellante,
si ritiene che debba essere dato minor peso
agli studi pubblicati da autori che non hanno dichiarato
l’esistenza di conflitti di interesse invece sussistenti e che
debba essere dato maggior peso ai risultati di studi condotti
da ricercatori esenti da tali conflitti, come ad esempio gli
studi effettuati da Hardell e collaboratori.
Nel caso in esame, possono concretizzare situazioni di
conflitto di interesse rispetto alla valutazione dell’effetto
sulla salute delle RF, ad esempio, quei casi in cui l’autore
dello studio ha effettuato consulenze per l’industria telefonica
o ha ricevuto finanziamenti per la realizzazione di
studi dall’industria telefonica oppure (come anche stabilito
dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in relazione
all’esposto presentato contro il prof. Ahlbom, poi destituito
dalla presidenza del gruppo di lavoro IARC sulle RF
proprio a causa della sua appartenenza all’ICNIRP) nel
caso in cui l’autore stesso sia membro dell’ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation). Infatti
l’ICNIRP è un’organizzazione privata, le cui linee guida
sulle RF hanno una grande importanza economica e strategica
per l’industria delle telecomunicazioni, con la quale
peraltro diversi membri dell’ICNIRP hanno legami attraverso
rapporti di consulenza ...Aparte possibili legami con
l’industria, appare evidente che i membri dell’ICNIRP
dovrebbero astenersi dal valutare l’effetto sulla salute di
livelli di RF che l’ICNIRP stesso ha già dichiarato sicuri e
quindi non nocivi per la salute (Hardell, 2017)” (v. pag.
107 relazione). L’impostazione dei Consulenti d’Ufficio è
del tutto condivisibile, essendo evidente che l’indagine, e
le conclusioni, di autori indipendenti diano maggiori
garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate,
gestite o finanziate almeno in parte, da soggetti interessati
all’esito degli studi.
L’ampia letteratura scientifica citata ed applicata dai
Consulenti d’Ufficio, del tutto indipendente, deve quindi
ritenersi affidabile, così come le conclusioni, a livello
epidemiologico, a cui essa è pervenuta.
Del resto, proprio in una controversia nei confronti dell’INAIL
relativa a malattia professionale (tumore intracranico)
per esposizione a radiofrequenze da telefono
cellulare, la S.C. ha ritenuto che “L’ulteriore rilievo
circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante
la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati
cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte
produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico
fondamento delle conclusioni accolte” (v. Cass.
12.10.2012 n. 17438).
Trattandosi di malattia professionale non tabellata e ad
eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro,
indubbiamente gravante sul lavoratore, per costante giurisprudenza
di legittimità deve essere valutata in termini di
ragionevole certezza, e quindi, esclusa la rilevanza della
mera possibilità dell’origine professionale, essa può essere
ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità
(cfr., tra le molte, Cass. 10 aprile 2018 n. 8773), grado che,
per le ragioni illustrate, è emerso dalla c.t.u. disposta nel
presente grado.
La percentuale di invalidità nella misura del 23%, già
riconosciuta nella c.t.u. disposta dal Tribunale e ribadita
dalla consulenza espletata nel presente grado, è stata
espressamente accettata dall’appellato (v. pag. 3, punto a,
memoria appellato).
In conclusione, l’appello dev’essere respinto.
Condividi
Condividi
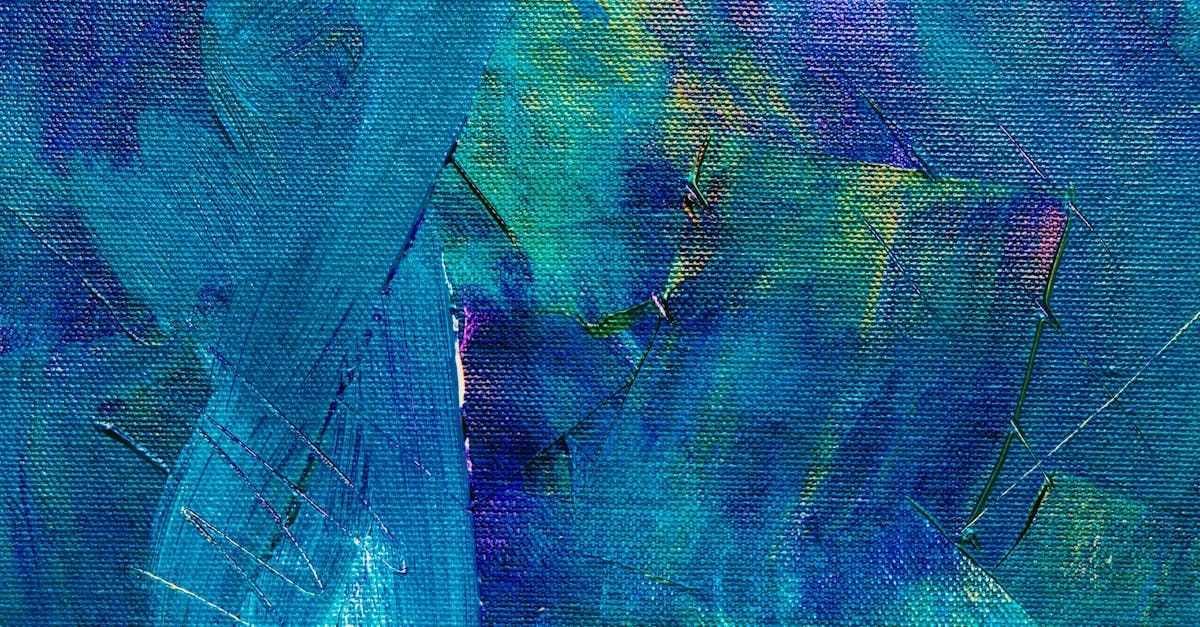
« Nulla è più dolce dell’amore, ogni altra felicità gli è seconda; dalla bocca sputo anche il miele. Così dice Nosside; solo chi non è amato da Cipride ignora quali rose siano i suoi fiori. » Frammenti di Nosside in Antologia Palatina, libro V, 170 Meleagro di Gadara. L’Enciclopedia Italiana ha selezionato il termine “femminicidio ” quale parola dell’anno 2023, nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono. “ Come Osservatorio della lingua italiana – spiega infatti Va l e r i a D e l l a Va l l e , c o d i r e t t r i c e scientifica del “Vocabolario Treccani” – non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso della parola “femminicidio” in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere ”. Ebbene, a febbraio 2024, il Parlamento Europeo e gli Stati dell’Unione hanno raggiunto l’accordo sulla Direttiva Europea sulla violenza di genere, la prima legge europea che si occupa della materia. L'obiettivo è di rendere omogenea la lotta alla violenza sessista nell'Unione Europea, eliminando e superando normative distanti e disparate fra di loro, vigenti fra i vari Stati. Rappresenta una pietra miliare, perché è il primo strumento giuridico, completo a livello UE, destinato a contrastare la violenza contro le donne. La futura Direttiva si occuperà di cyberbullismo, incitamento all'odio online e violenza, matrimonio forzato, mutilazione genitale, violenza informatica, molestie sessuali attraverso mezzi digitali. Comprenderà un elenco di circostanze aggravanti; l'intento è di punire le violenze effettuate per motivi di orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale, convinzioni politiche, oppure per preservare o ripristinare " onore" ; sono miglioratele procedure per la sicurezza e la salute delle vittime, una migliore attività di segnalazione, prevenzione e raccolta di prove da parte delle autorità. Rappresenta tuttavia una grave lacuna della Direttiva l’esclusione della sua applicazione alle donne migranti. Ulteriore perplessità è costituita dal fatto che non includerà uno dei reati più gravi, ossia lo stupro, il fatto più violento alla persona e alla libertà delle donne. Il mancato inserimento dipende da una serie di fattori che la Commissione Europea ha tentato di dirimere. Infatti, a marzo 2022, la Commissione europea aveva formulato la proposta di definire la violenza sessuale, identificandola quale rapporto in assenza del consenso. Quindi qualsiasi rapporto sessuale non concordato sarebbe stato tipizzato come stupro; le vittime sarebbero state agevolate dal punto di vista processuale, in quanto non avrebbero dovuto fornire la prova che fosse stata utilizzata la forza, la minaccia o la coercizione. Alcuni paesi già hanno adottato, in ambito nazionale, la definizione del reato quale rapporto basato sulla mancanza di consenso. Diversi paesi, anzi ben 14, si sono opposti ad una simile definizione. La Germania e la Francia sostengono che la materia specifica appartiene alla potestà legislativa penale nazionale e non è fra quelle delegate all'Unione. La Polonia e l'Ungheria sono ideologicamente contrari al fatto che il consenso possa costituire la base per la distinzione o meno del rapporto lecito dall'illecito. La domanda chiave è su “ cosa o come” intendere il rapporto consensuale. Secondo alcune correnti del femminismo, “ il consenso è impossibile ”. La disuguaglianza di potere tra uomini e donne è così grande che, di fatto, ogni accordo è viziato a livello del sistema sociale. Finché ci sarà disuguaglianza di potere ci sarà violenza. La libertà di una delle parti, quella delle donne, è un’apparenza. Il rapporto diventa un obbligo, in quanto in una società patriarcale si vive male e con alibi. Si tratta di una visione autoritaria, manichea, e come tale è inaccettabile. Secondo altre teorie il consenso è possibile e, per di più, dovrebbe essere obbligatorio, affermativo, esplicito. Da un lato propone che “ il consenso non è impossibile, ma è difficile ”, per cui bisognerebbe “assicurarsi” che la donna esprima un chiaro “ sì ” oppure un “ No ” è no” , ma ciò non appare accettabile in quanto immergerebbe il rapporto in una visione di tipo contrattualistico, lontana dalla realtà effettuale. Secondo altri il “ consenso è molto facile .” Basta sapere cosa vogliamo e verbalizzarlo. Quanto più inequivocabile è questa espressione positiva della volontà di fare sesso, tanto meglio è. Non dobbiamo prestare attenzione solo alla volontà, ma anche al desiderio. Anche questa teoria appare non recepibile, in quanto collega la volontà al desiderio, come se il desiderio fosse sempre trasparente e intelligibile e, invece, non abbia momenti di ambiguità, per cui un “no”, molte volte è un ”sì”. Il consenso può essere non necessariamente entusiastico e anche non esplicito, ma certamente è delimitato dall’area legale e penale, per cui se non c'è volontà e non c’è consenso, allora si tratta di violenza; altro limite è rappresentato dall’etica, per cui se manca la volontà perché c’è stata un’incomprensione, un errore, manca il sentimento fra amanti, ma non c’è aggressione, intimidazione, allora non è un crimine. La direttiva costituisce un traguardo nella lotta alla violenza di genere, ma dimostra la persistenza di una mentalità passata e contraddittoria, in quanto la stessa Convenzione di Istanbul , adottata da quasi tutti gli Stati Europei, all'art. 36, comma 1 lett. a, obbliga gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per perseguire penalmente i responsabili dei comportamenti intenzionali, fra cui lo stupro, definito come "atto sessuale non consensuale". Ebbene, dopo la ratifica del 2013, l’articolo 609-bis c.p. non ha subito modifiche per allinearlo alla Convenzione di Istanbul. In particolare, la sua formulazione non menziona il consenso, rappresentando una vera e propria lacuna giuridica. Sul punto soccorre la giurisprudenza e la dottrina che invece lo considerano come elemento essenziale del reato. La recente sentenza della Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il consenso debba essere presente al momento dell'atto e, malgrado il comportamento provocatorio, anche durante tutto l'atto sessuale. In precedenza aveva affermato che «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente ». Alcune pronunce hanno riconosciuto la configurabilità, in astratto, dell'esimente putativa del consenso nei reati sessuali, come errore fondato sul contenuto espressivo , in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla persona offesa. Il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’autore; l’assenza di consenso non vale come sì; il consenso dovrebbe essere esplicito ed inequivocabile. Il richiamo è, quindi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, alla parità di genere, all’educazione e al rispetto reciproco della dignità umana, quale base per le relazioni umane. BIBLIOGRAFIA Il termine " femminicidio " deriva dall’unione del sostantivo femminile “femmina” a cui è aggiunto il suffisso “cidio”, similmente a omicidio, deicidio, regicidio, ecc. Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803. https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html . Secondo la Platform for undocumented migrants (Picum), una ong con base in Belgio che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa, ha denunciato la cancellazione delle norme che avrebbero protetto le donne migranti, in particolare coloro senza documenti o con un permesso di soggiorno temporaneo. Clara Serra, “Il senso del consenso”, Nuevos cuadernos Anagrama, 2024; intervista su https://youtu.be/AuCIVgPY1 La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge del 27/6/2013 n.77. Invece il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, è la prima "legge contro il femminicidio", così nel suo preambolo: "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica". Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 32447 del 26 luglio 2023: «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599 “In tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, 8 pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali e consiste in un fenomeno di natura psichica che concerne lo stato soggettivo del soggetto passivo, non quello del soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il dissenso è fuori dalla valutazione degli elementi soggettivi del reato e quindi del dolo. Diversa invece è la valutazione in ordine alla coscienza e alla volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto. Nel reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere la persona offesa a compiere o a subire un atto sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso di questa. Pertanto, l'errore sul dissenso, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., consiste nell'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza all'atto sessuale poste in essere dalla persona offesa. Trattandosi di un errore sul fatto, è necessario che il soggetto, che ha agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, debba dare pienamente conto degli elementi fattuali che hanno determinato in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, l'erroneo convincimento dell'esistenza del consenso”. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 06/12/2023) 05/03/2024, n. 9316. Articolo estratto da “L’Eco Giuridico" n. 4 de1 8/04/2024- Centro Studi Zaleuco Locri





